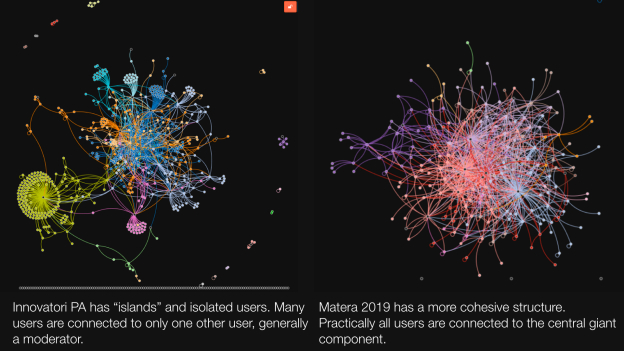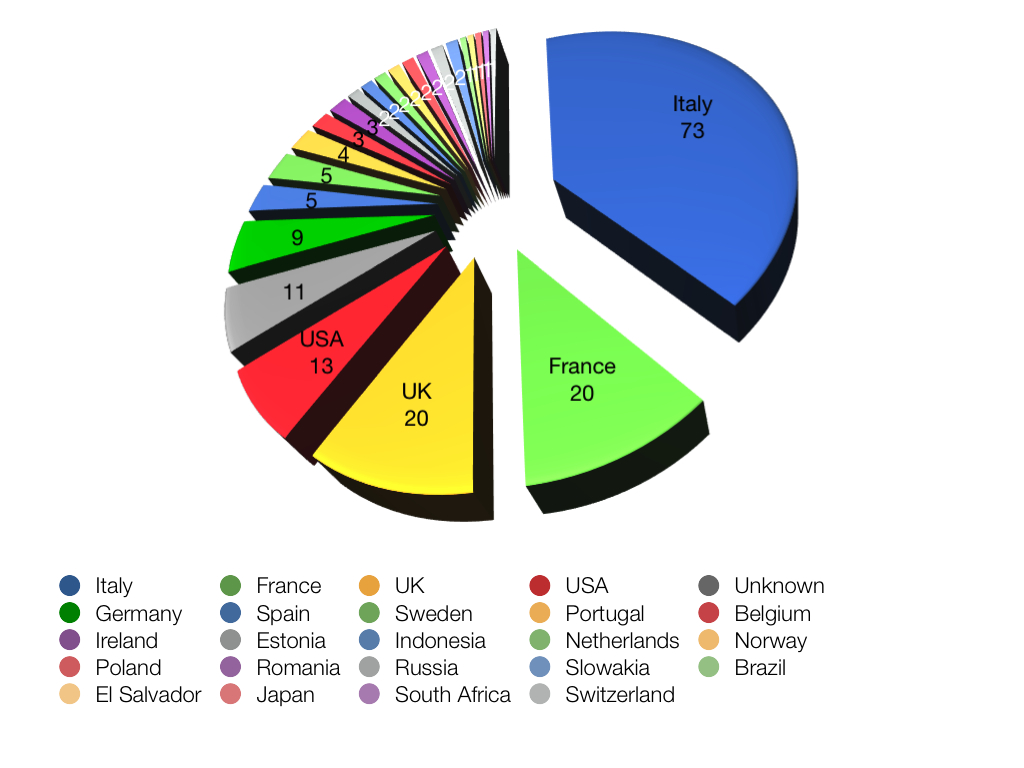Gli accordi di corridoio e le clientele sono strumenti classici di governo. Molte persone, però, non li amano, e non se ne fidano. Preferiscono una governance aperta e trasparente. Io sono tra queste, e probabilmente anche tu.
Ispirato da questi valori, ho guardato Internet diffondersi su tutto il pianeta, e ho visto un’opportunità. Ho dedicato parecchi anni di lavoro a esplorare come le forme di comunicazione che Internet rendeva via via possibili potessero rendere la democrazia migliore, più intelligente. Gran parte di questo lavoro era pratico. Consisteva di progettare e realizzare progetti di governo aperto (open government), prima in Italia (Kublai, Visioni Urbane), poi in Europa Edgeryders).
Circa dieci anni fa, le poche persone che, in tutto il mondo, lavoravano su questi temi hanno cominciato a entrare in contatto gli uni con gli altri. Abbiamo cominciato a scambiarci esperienze, a riflettere insieme, a costruirci luoghi di incontro. Continuiamo a farlo anche oggi. E c’è una novità: questo dibattito si sta spostando. Non stiamo più parlando degli argomenti che ci appassionavano nel 2009. Se hai a cuore la democrazia, questa è una notizia in parte buona e in parte cattiva, e comunque importante e eccitante.
Alla fine degli anni duemila, pensavamo che Internet avrebbe migliorato il funzionamento della democrazia abbassando i costi di coordinamento tra i cittadini. Questo funzionava in tutti gli ambiti. Rendeva tutto più facile. Trasparenza? Basta mettere le informazioni su un sito, e renderlo rintracciabile dai motori di ricerca. Partecipazione? I sondaggi online costano poco. Collaborazione tra governo e cittadini? Puoi usare wiki e forum online, e avvantaggiarti dell’ubiquità della Rete per attirarvi le persone che hanno la conoscenza che serve all’azioen di governo. Avevamo la teoria. Avevamo (un po’ di) esperienza pratica. Cavalcavamo l’onda della diffusione inarrestabile di Internet. Con l’elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti nel 2008, avevamo anche il primo leader globale che sosteneva questi principi, sia a parole che nei fatti. Stavamo vincendo.
Ci aspettavamo di continuare a vincere. Avevamo un vantaggio strategico: il governo aperto non richiedeva un cambiamento culturale per essere messo in pratica. L’adozione delle sue pratiche non era una rivoluzione; era più un retrofit, un innesto di nuova tecnologia senza modificare l’infrastruttura esistente. Per spingerle usavamo parole familiari alla vecchia guardia: trasparenza, accountability, partecipazione. Erano come talismani. I dirigenti pubblici non erano sempre entusiasti di ciò che facevamo, ma non potevano certo dichiararsi apertamente contro questi valori. E, quando i nostri progetti venivano realizzati, causavano il cambiamento culturale. I servitori dello stato imparavano a lavorare in ambienti aperti e collaborativi; era difficile per loro ritornare al controllo dell’informazione e al need to know. Quindi, concludevamo, questa cosa può andare solo in una direzione: verso più Internet nelle pratiche di governo, più trasparenza, partecipazione, collaborazione. Il dibattito rifletteva questa posizione, e veniva riassunto in libri come The Wiki Government di Beth Noveck'(2009) and il mio Wikicrazia (2010).
Ora è cambiato tutto.
Me ne sono convinto leggendo due libri recenti. Uno è Smart Citizens, Smarter Governance, di Beth Noveck. L’altro è Complexity and the Art of Public Policy, di David Colander e Roland Kupers. Considero questi lavori un progresso rispetto a qualunque cosa sia stata scritta in precedenza.
Beth è un faro per chi si occupa di governo aperto. È stata tra i suoi pionieri, con un progetto che si chiama Peer2Patents. A causa di esso, il presidente Obama l’ha voluta nel suo transition team prima, e alla Casa Bianca più tardi. Ha moltissima esperienza a tutti i livelli, dalla teoria alla realizzazione a alla policy. E ha un messaggio per noi: l’open government sta fallendo. Ecco il passo più significativo:
Nonostante tutto l’entusiasmo per i benefici potenziali di una governance più aperta; il movimento open government ha avuto un impatto davvero modesto sul modo in cui prendiamo decisioni pubbliche, risolviamo problemi e allochiamo beni pubblici.
Perché? La causa immediata più importante è che le pratiche di governo sono scritte nella legge. Cambiare le leggi è difficile, e ha effettivamente bisogno di un cambiamento nella cultura dei legislatori incaricati di riformarle. La causa ultima è ciò che Beth chiama governo professionalizzato. Il ragionamento è questo:
- Per prendere decisioni sulla base dell’informazione disponibile, è necessario che quest’ultima sia filtrata, riaggregata, curata. Per fare questo servono esperti.
- Come facciamo a capire quando una persona è un esperto? Guardiamo se appartiene a una professione (medico, avvocato, biologo…). L’attività di governo è oggi completamente professionalizzata; solo il parere degli esperti è considerato utile (ma non è sempre stato così, anzi).
- Di conseguenza, “aprirsi significa esercitare muscoli civici che si sono atrofizzati”, e considerare i cittadini potenzialmente competenti a contribuire alla progettazione delle politiche pubbliche.
- Inoltre, le professioni sono esclusive per definizione. Ogni volta che prendono piede, si muovono per escludere i non-membri da quello che considerano il loro terreno. Oggi, tutte le persone importanti nei governi sono professionisti, e condividono l’idea che i cittadini comuni non hanno competenze utili. Interagendo tra loro, queste persone formano un ambiente di lavoro che rinforza questa loro convinzione. Risultato: “molti omaggi retorici all’idea di engagement, ma poca condivisione vera del potere”.
Oggi diamo per scontato che l’attività di governo sia professionalizzata. La consideriamo una specie di legge di natura. Ma non è così. Nel libro, Beth racconta in dettaglio come il governo si è professionalizzato negli Stati Uniti. All’inizio della loro storia, gli USA sono governati da agricoltori gentiluomini. L’amministrazione era guidata da un corpus di conoscenza chiamata citizen’s literature, che i servitori dello Stato imparano direttamente sul lavoro. Con il tempo, sempre più persone vengono assunte nell’amministrazione pubblica. Questo processo creato e fa crescere in numeri e potere una nuova classe di professionisti del governo – persone che non hanno mai fatto altro nella loro vita, né si aspettano di farlo. Questa classe usa il suo potere per consolidare la propria posizione, rendendo la burocrazia pubblica una professione. Codici di condotta vengono redatti. Le università creano dipartimenti di diritto e scienze sociali, luoghi di addestramento e reclutamento dei burocrati del nuovo tipo. Tutto questo accade in sintonia con un movimento di tutta la società verso la misurazione, la standardizzazione e l’ordine amministrativo.
Beth ritrae questo movimento in un affresco ricco e convincente; è una delle parti del libro che preferisco. Poi, spiega che i nuovi modi di mettere le competenze degli esperti a disposizione dei policy makers sono illegali negli Stati Uniti. Perché? A causa del Paperwork Reduction Act. Questa legge non intendeva vietare la ricerca di esperti via Internet (è del 1995), ma è scritta in modo che la formazione di comitati che consigliano il governo sia strettamente regolamentata e tecnicamente difficile. Ma perché il Paperwork Reduction Act è sembrato necessario? Il legislatore americano stava tentando di proteggere la burocrazia da interferenze e pressioni da parte di coloro che la burocrazia deve regolare. Per fare questo, ha relegato chiunque non sia un professionista del governo al ruolo di rappresentanza degli interessi. Questo vuol dire che i cittadini sono importanti non per quello che sanno, ma per chi rappresentano, per “chi li manda”. È emersa un’architettura di governo professionalizzato che protegge sé stessa, senza bisogno di un architetto.
Architetture senza architetti? Questa è complessità. Il viaggio intellettuale di Beth l’ha portata alle dinamiche dei sistemi complessi. Lei non lo scrive proprio in questi termini, ma è chiaro. Questa storia ha feedback positivi, effetti di lock-in, emergenza. Beth ha dovuto imparare a pensare in termini di sistemi complessi per navigare le politiche pubbliche. La capisco bene, perché la stessa cosa è accaduta a me. Mi sono dovuto insegnare la matematica delle reti come strumento principale per pensare la complessità. E dovevo imparare a pensare la complessità, perché mi occupavo di politiche pubbliche, e quello era l’unico modo di farle funzionare.
L’altro libro che ho citato, quello di David Colander e Roland Kupers, parte direttamente dalla scienza dei sistemi complessi. La sua domanda è: come sarebbero le politche pubbliche se fossero progettate in una prospettiva di sistemi complessi?
Le risposte sono affascinanti. La polarizzazione “libero mercato contro stato” sparirebbe. Sparirebbe anche il predominio della scienza economica, e le politiche economiche verrebbero considerate parte delle politiche sociali. Lo stato promuoverebbe norme sociali benefiche, così che i cittadini vogliano fare scelte vantaggiose per sé e per gli altri invece di essere costretti a farle dalla legge. Le agenzie governative sarebbero fortemente interdisciplinari. Sperimentazione e reversibilità sarebbero incorporati in tutte le politiche pubbliche.
Colander e Kupers hanno scritto il loro libro senza avere letto quello di Beth, e viceversa. Ma i due libri convergono alla stessa conclusione: fare politiche pubbliche nel ventunesimo secolo è un problema di sistemi complessi. Senza un approccio basato sulla complessità, le politiche falliscono. Condivido questa conclusione. In effetti, ho cominciato a studiare scienze della complessità nel 2009. Negli ultimi quatto anni ho approfondito in particolare la scienza delle reti. L’ho fatto perché anch’io progettavo politiche pubbliche; dovevo districarmi in situazioni intricate, e il potere esplicativo del pensiero della complessità era evidente. Nei primi anni il mio percorso è stato molto solitario: oggi sono sollevato e orgoglioso di trovarmi sullo stesso sentiero di gente intelligente come Beth, Colander e Kupers.
Ma c’è ancora un pezzo mancante. Pensare in termini di sistemi complessi ci aiuta a capire perché le politiche pubbliche non funzionano. Non sono ancora convinto che ci aiuti a farle funzionare davvero. Questo tipo di scienza ha funzionato bene nelle scienze naturali. La fisica e la biologia cercano di capire la natura, non di cambiarla. Non c’è policy qui. La natura non fa errori.
Quindi, capire un fenomeno in profondità significa rispettarlo, almeno in parte. Prova a indicare un problema sociale a uno studioso di sistemi complessi, per esempio la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. Ti mostrerà la legge di potenza della distribuzione; lo spiegherà con una dinamica di feedback positivo, tipo success breeds success; aggiungerà che questo succede molto spesso in natura; e descriverà quanto è difficile allontanare un sistema complesso dal suo attrattore. Il pensiero della complessità funziona benissimo per individuare in anticipo politiche inefficaci e controproducenti. Per ora, non ha funzionato altrettanto bene a individuare cosa possiamo fare che, invece, sia efficace.
Gli autori di entrambi i libri hanno dei suggerimenti per i policy makers. Ma non sono particolarmente convincenti.
La soluzione principale di Beth è una specie di database ricercabile per esperti. Un policy maker che ha bisogno di competenze potrebbe scrivere, per esempio, “open data” in un campo di ricerca, e connettersi con persone che sanno molte cose sugli open data. Questo dovrebbe funzionare bene per i problemi ben definiti, in cui il policy maker sa con certezza dove cercare una soluzione. Ma molti problemi di policy interessanti non sono affatto ben definiti. L’inquinamento atmosferico in città è un problema tecnologico? Allora dovremmo intervenire sul settore automobilistico per fargli produrre auto meno inquinanti. O è un problema di pianificazione urbana? Occorre modificare il piano regolatore, avvicinando i luoghi di lavoro a quelli di residenza per ridurre il pendolarismo. Un problema di organizzazione del lavoro, forse? Dovremmo incoraggiare i datori di lavoro a eliminare i loro uffici e dare ai dipendenti strumenti software perché possano lavorare da casa? Un momento, forse è un problema di mode: potremmo usare il marketing per rendere le biciclette più popolari. Nessuno lo sa. Probabilmente il problema è tutte queste cose, più chissà quante altre. Non è affatto chiaro a priori che tipo di esperto ti serve, tanto più che ogni mossa che fai in una delle dimensioni del problema influenzerà le altre.
Non è ancora finita, Le categorie stesse in cui raggruppare gli esperti sono socialmente determinate, e in continua trasformazione. Puoi immaginare un policy maker che cerca un esperto in open data nel 1996? No, perché il concetto non esisteva. Il database di Beth può, oggi, aiutarci a trovare esperti in open data solo perché qualcuno ha ricombinato le componenti di ciò che oggi chiamiamo open data (tecnologie, standard, licenze etc.) in un modo nuovo, che risolveva certi problemi. Questo ha funzionato così bene che ha ricevuto un’etichetta, appunto open data, che oggi potete mettere nel vostro CV in modo che una ricerca nel database di Beth vi trovi. Quindi, la soluzione di Beth può trovare esperti di discipline già codificate, ma non quelli delle soluzioni in via di codificazione; ma sono questi ultimi quelli che contano, quelli che stanno sulla frontiera dell’innovazione.
Colander e Kupers hanno le proprie soluzioni, come racconto sopra. Sono soluzioni brillanti e sensatissime. Sono anche in netta rottura con il modo in cui il governo funziona oggi. È improbabile che emergano per caso. Chiunque abbia provato a fare innovazione in un’amministrazione pubblica sa quanto sia difficile fare passare qualunque cambiamento, anche piccolo. Come funzionerebbe la riprogettazione radicale auspicata da Colander e Kupers? Per diktat di qualche leader visionario? Possibile, ma ricorda: la modalità attuale di funzionamento della macchina governativa è emersa (“architettura senza architetti”). Entrambi i libri offrono resoconti sofisticati di questo emergere. Con tutta l’ammirazione che ho per i loro autori, mi pare incoerente che propongano, invece, una soluzione imposta dall’alto.
Quindi, dove vanno le politiche pubbliche del ventunesimo secolo? Al momento, non vedo alternative ad abbracciare il pensiero della complessità. È molto forte nell’analisi, e una volta che cominci a vedere le cose in questi termini è impossibile smettere di vederle. Inoltre, fornisce soluzioni implementabili localmente. Per esempio, in certi casi puoi convincere lo stato a fare cose coraggiose e innovative in via sperimentale, e sperare che quello che succede nell’esperimento venga imitato. Per ora, questo dovrà bastarci. Ma va bene così. L’età dell’innocenza è finita: oggi sappiamo che non c’è nessuna soluzione facile e veloce. Forse un giorno avremo soluzioni sistemiche non velleitarie: se mai ci arriveremo, è probabile che Beth Noveck, David Colander e Roland Kupers siano i primi a trovarle.
Photo credit: Cathy Davey on flickr.com