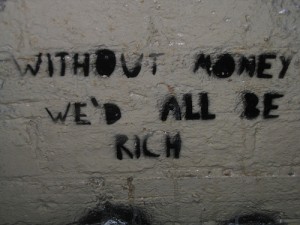I giovani europei hanno difficoltà a rendersi completamente indipendenti. In Europa il problema è particolarmente sentito, perché il nostro modello sociale è basato sullo status di lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato, che sblocca molti diritti sociali ed economici (in Francia, dove vivo ora, se sei disoccupato non hai diritto all’assistenza sanitaria). Questo crea tensioni, perché costringe i giovani a cercare di ottenere questo status ad ogni costo, anche se è diventato molto difficile e anche se alcuni di loro vorrebbero cercare strade diverse. Risultato: il 20% dei 15-34enni, in Europa, non lavora, non studia, non si sta formando. Non è nemmeno più un problema di giovani: i giovani sono in prima linea e soffrono di più, ma tutte le categorie di cittadini stanno perdendo autonomia.
Il paradosso è che la generazione che è giovane adesso è probabilmente la più creativa, generosa, idealista e collaborativa che sia mai vissuta. Dovunque, i giovani creano dal nulla nuovi lavori e nuovi settori economici, come i miei amici di CriticalCity o gli straordinari ragazzi di Blackshape Aircraft; sperimentano modi di condividere risorse, dal divano letto di casa dei couchsurfers alle auto, o stili di vita alternativi, lontani dai sentieri più battuti; costruiscono nuovi canali per la partecipazione politica e la costruzione di senso collettivo in un tempo di grave crisi di legittimità della democrazia rappresentativa. Queste persone non si conoscono tra di loro e agiscono indipendentemente, eppure si ha la netta sensazione di una coerenza di fondo tra i loro progetti, come se essi fossero tasselli di un comune futuro emergente. Il video di OpenStreetMap 2008 qui sopra parla ovviamente di tutt’altro, ma potrebbe rappresentare questo emergere; e mi dà la stessa sensazione di commozione e speranza.
Il Consiglio d’Europa ha avuto un’idea: cercare di stanare queste esperienze; riunirle; validarle attraverso un metodo peer-to-peer; e aggregarle per proporre alla Commissione Europea e agli stati membri una strategia nuova. Questa strategia si potrebbe chiamare adattiva: in concreto, si tratta di:
- capire cosa i giovani stanno già facendo per costruire il mondo in cui tutti abiteremo tra vent’anni. Questo è un buon indicatore del mondo che vogliono: se si sbattono per costruirlo vuol dire che sono motivati.
- se è possibile, aiutarli a farlo, nel senso di creare le condizioni perché queste strategie – che oggi richiedono molto sacrificio e molta iniziativa e sono accessibili solo a una minoranza – diventino praticabili per un giovane medio.
- se non è possibile aiutarli, almeno evitare di ostacolarli proiettando su di loro il modello sociale ed economico degli anni 70, che è quello in cui tanti decisori europei senior sono cresciuti, ma non per questo è necessariamente il migliore o il più adatto ai tempi.
Questa cosa verrà fatta con un progetto web, in cui l’interazione con l’istituzione è aperta e costruttiva. Il risultato finale verrà presentato in una conferenza di alto profilo a Bruxelles, probabilmente a fine maggio 2012. Ho l’onore di dirigere questo progetto, e la fortuna di avere avuto la possibilità di mettere insieme un team stellare (ve lo presenterò in un post successivo). Devo ringraziare moltissimo la Divisione Ricerca e Sviluppo sulla Coesione Sociale del Consiglio d’Europa per avere creduto in questo progetto, e riconoscerne il coraggio nel mettere in pista un progetto così aperto.
Il progetto si chiama Edgeryders. La piattaforma lancerà a fine ottobre; per ora abbiamo messo online un blog per cominciare a interagire. Vienci a trovare, e, se ti sembra credibile, passa parola: avremo bisogno di tutta la conoscenza e tutto l’aiuto possibile. E tu, cioè voi, ma anche noi, insomma tutti quanti noi siamo i veri esperti della costruzione del futuro: ci combattiamo tutti i giorni.